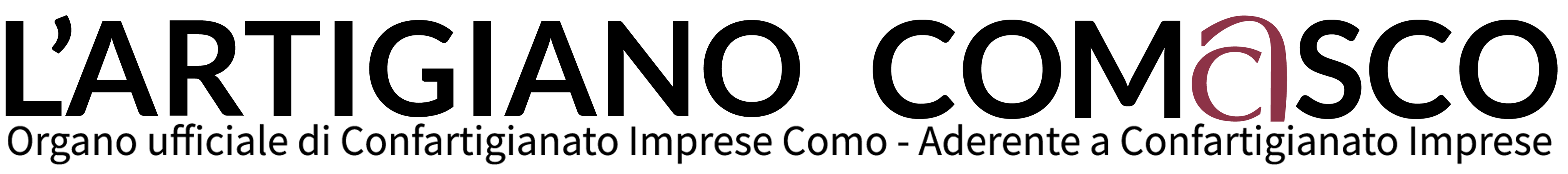Consigli alle Imprese

FINANZA AGEVOLATA: ISTRUZIONI PER L’USO
Nel 2025 il panorama della finanza agevolata in Italia si presenta più complesso che mai. Temi come la cumulabilità delle agevolazioni e il divieto di doppio finanziamento rappresentano nodi delicati per imprese ed enti. Il quadro normativo è infatti frammentato: regolamenti europei, interpelli, FAQ istituzionali, decreti nazionali, bandi regionali e circolari ministeriali si intrecciano creando un mosaico difficile da decifrare.
In questo scenario, la corretta gestione delle risorse, dal PNRR ai fondi FESR, fino ai crediti d’imposta, richiede non solo competenze tecniche, ma anche una visione d’insieme.
La sfida per le imprese è quindi duplice: intercettare le opportunità disponibili e, al tempo stesso, evitare criticità in fase di rendicontazione o cumulo. Una guida esperta diventa oggi uno strumento imprescindibile per trasformare la complessità normativa in un reale vantaggio competitivo.
Cosa significa cumulabilità nei bandi
Nel linguaggio della finanza agevolata, il termine cumulabilità indica la possibilità di sommare più incentivi su un medesimo investimento, che si tratti di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati o crediti d’imposta, a condizione che non venga superato il 100% del costo complessivo sostenuto dall’impresa. Si tratta di una regola tanto semplice quanto strategica: da un lato permette alle aziende di ottimizzare i benefici economici derivanti dalle misure disponibili, dall’altro impedisce il cosiddetto doppio finanziamento, ossia la copertura della stessa spesa con più agevolazioni. Un esempio pratico aiuta a chiarire: se un’impresa investe 100 nell’acquisto di un macchinario, potrà teoricamente ottenere un contributo pubblico del 40%, cumularlo con un credito d’imposta del 20% e accedere a un ulteriore incentivo fino a coprire il restante 40%. L’unico vincolo invalicabile è che la somma degli aiuti non superi mai l’importo effettivamente speso. Questa regola, prevista a livello nazionale ed europeo, ha una funzione precisa: garantire equità e proporzionalità nell’uso delle risorse pubbliche, evitando che un’impresa possa trarre un vantaggio eccessivo da un singolo investimento.
Divieto di doppio finanziamento: cosa significa?
Il divieto di doppio finanziamento e la cumulabilità delle agevolazioni sono due concetti che spesso vengono confusi, ma che in realtà rispondono a logiche molto diverse. Il primo, sancito dal Regolamento (UE) 2021/241 che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) del PNRR, vieta in modo tassativo che la stessa spesa (ad esempio una fattura da 10.000 €) venga rimborsata due volte con fondi pubblici PNRR, sia essi nazionali o europei. Proprio per questo motivo, in fase di richiesta di contributo, viene richiesto di inserire il Codice Unico di Progetto (CUP): uno strumento di tracciabilità che consente alle autorità di controllo di identificare in maniera univoca l’investimento e verificare che non vi sia alcuna sovrapposizione di finanziamenti. Il CUP, in altre parole, funziona come una sorta di “impronta digitale” del progetto, indispensabile per garantire trasparenza, correttezza amministrativa e rispetto del divieto di doppio finanziamento. La cumulabilità, invece, rappresenta una possibilità di combinare più strumenti di agevolazione, purché ciascuno si applichi su porzioni diverse dello stesso investimento ed è consentita solo se le regole del bando lo permettono e senza mai superare il 100% della spesa ammissibile. In concreto, se un’impresa realizza un investimento da 100.000 € e ottiene un contributo PNRR pari al 60% della spesa ammissibile, quella quota non potrà essere coperta da ulteriori incentivi: sarebbe un doppio finanziamento e quindi vietato. Sulla parte residua pari al 40%, invece, l’azienda potrà cumulare altri strumenti, come crediti d’imposta o contributi regionali, purché non si superi mai l’importo complessivo effettivamente speso. Distinguere correttamente questi due concetti è fondamentale: significa da un lato massimizzare le opportunità offerte dal sistema di finanza agevolata, dall’altro evitare rischi di contestazioni in fase di rendicontazione e controlli, che potrebbero tradursi nella perdita dei benefici ottenuti.
Risorse pubbliche e agevolazioni: le regole per cumulare PNRR, FESR e crediti d’imposta
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha introdotto nuove sfide normative, aumentando la complessità nella gestione delle risorse pubbliche. La Regione Lombardia, consapevole di questa complessità, ha cercato di fornire chiarimenti attraverso diversi provvedimenti normativi, culminati nel decreto n. 10G30 del 30 luglio 2025, che definisce le modalità operative per la verifica e la gestione del cosiddetto doppio finanziamento tra PNRR e il Programma Regionale FESR 2021-2027. In particolare, il decreto stabilisce che le fatture agevolate con risorse PNRR possono essere considerate solo ai fini del raggiungimento della spesa minima prevista dai bandi regionali, ma non per il calcolo di ulteriori agevolazioni. Poiché l’entrata in vigore del decreto non ha effetto retroattivo, per alcune domande ancora aperte e attualmente in fase di rendicontazione, è necessario distinguere tra le spese ammissibili, cioè quelle considerate per la percentuale di realizzazione del progetto, comprese le spese già oggetto di agevolazioni PNRR, e le spese agevolabili, ossia quelle sulle quali saranno calcolati gli incentivi, escludendo quindi quanto già finanziato dal PNRR. L’obiettivo è evitare che lo stesso costo generi benefici economici multipli, in piena conformità con la regola comunitaria che vieta il doppio finanziamento.
Sul fronte dei crediti d’imposta per investimenti tecnologici, il panorama è in continua evoluzione, in particolare con i meccanismi Transizione 4.0 e Transizione 5.0, quest’ultimo attivo per il biennio 2024-2025. La regola principale riguarda la cumulabilità: è infatti possibile cumulare i crediti d’imposta 4.0 e 5.0 con altre agevolazioni e bandi, purché siano calcolati su quote di costo distinte, rispettando i limiti di cumulabilità previsti. Un aspetto spesso sottovalutato riguarda il beneficio fiscale indiretto: i crediti d’imposta 4.0 e 5.0 generalmente non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES e IRAP, migliorando in termini concreti il vantaggio netto per l’impresa rispetto a un semplice contributo.
Art. 8 GBER Aiuti di Stato e misure generali, conoscerne le differenze è fondamentale per le imprese
Spesso si parla di aiuti di Stato e di misure di carattere generale o fiscale, ma pochi sanno esattamente in cosa differiscono e perché questa distinzione sia cruciale per gli imprenditori. Gli aiuti di Stato sono incentivi mirati, selettivi e rigorosamente censiti a livello europeo. Soggetti a limiti stringenti e al divieto di doppio finanziamento, devono rispettare regolamenti precisi per evitare contenziosi e sanzioni. Al contrario, le misure di carattere generale, come alcune agevolazioni fiscali o crediti d’imposta, offrono un regime più ampio: possono essere accessibili a imprese di qualsiasi settore o dimensione e, in molte situazioni, non rientrano tra gli aiuti di Stato o sono esentate da notifica, garantendo una maggiore possibilità di cumulo. L’articolo 8 del Regolamento di esenzione per categoria (GBER, Reg. UE n. 651/2014) disciplina le possibilità di combinare questi strumenti. Il cumulo è vietato solo se la somma degli incentivi supera l’intensità massima prevista o finanzia le stesse quote di costo. Comprendere questa distinzione è essenziale: da un lato permette di rispettare la normativa europea e nazionale, evitando rischi di recupero fondi e sanzioni; dall’altro rappresenta un’opportunità concreta per massimizzare i benefici pubblici sugli investimenti imprenditoriali. Nel 2025, con il quadro normativo in continua evoluzione e l’intreccio tra circolari ministeriali, regolamenti europei, regimi fiscali e bandi regionali, confrontarsi con un professionista esperto non è solo un’opportunità ma una scelta strategica per navigare senza rischi nel complesso mondo degli incentivi pubblici.
Una casistica particolare - focus fotovoltaico, revamping e incentivi: come orientarsi tra aiuti pubblici e regole europee
L’investimento in un impianto fotovoltaico rappresenta oggi una delle opportunità più interessanti per le imprese che vogliono ridurre i consumi energetici e accedere a incentivi pubblici. Se l’installazione è combinata con altri interventi volti a migliorare l’efficienza energetica, è possibile accedere al regime di aiuto GBER, art. 41, che sostiene specificamente progetti finalizzati al risparmio energetico. Se invece l’obiettivo dell’investimento è esclusivamente la produzione di energia da fonti rinnovabili, il riferimento normativo corretto è il GBER, articolo art. 36, dedicato a questo tipo di iniziative. In entrambi i casi, gli imprenditori possono fruire di incentivi pubblici ma devono rispettare le regole di cumulabilità tra incentivi illustrate in precedenza, per evitare contenziosi e richieste di restituzione dei fondi. La situazione diventa più complessa quando l’intervento riguarda il revamping di impianti esistenti, soprattutto se questi già usufruiscono di incentivi GSE come il Conto Energia o lo Scambio sul Posto (SSP). Il Conto Energia è un incentivo in conto esercizio che interviene sui ricavi derivanti dalla produzione di energia. Essendo qualificato come aiuto di Stato notificato e autorizzato dalla Commissione Europea, pertanto gli investimenti di revamping su impianti già incentivati dal conto energia non sono cumulabili con bandi che erogano contributi a fondo perduto, come quelli finanziati dal PNRR. Lo Scambio sul Posto (SSP) è invece un meccanismo di compensazione economica dell’energia immessa in rete. Non si tratta di un contributo diretto sul costo dell’investimento, ma di un vantaggio economico legato all’energia prodotta. Di conseguenza, lo SSP rientra tra le misure generali e non costituisce aiuto di Stato. Alcuni bandi, tuttavia, vietano comunque il cumulo con le misure generali se esse rappresentano un beneficio economico collegato allo stesso investimento. In generale, quindi, nel caso di revamping di impianti già incentivati da misure GSE, occorre considerare che la cumulabilità con altri incentivi è esclusa, soprattutto quando si tratta di aiuti di Stato o di misure assimilabili.
Per quanto riguarda il credito d’imposta “Transizione 5.0, se l’investimento riguarda una nuova installazione o l’ampliamento di un impianto esistente, anche incentivato dalle misure GSE, non sussiste generalmente il problema del cumulo: l’ampliamento dovrà essere registrato come unità di produzione separata, e l’incentivo fiscale si applicherà esclusivamente alla parte aggiuntiva, che non risulta già incentivata dal Conto Energia. Diverso è il caso del revamping di un impianto già incentivato dal Conto Energia. Attualmente, non esiste un riscontro ufficiale da parte del Ministero dell`Economia e delle Finanze (MEF) sul cumulo con altri incentivi. Nei prossimi 5-7 anni il revamping di impianti fotovoltaici già esistenti diventerà sempre più frequente, sia per ragioni tecniche sia per le esigenze di efficientamento energetico. Prepararsi per tempo, comprendere le regole di cumulabilità tra incentivi, aiuti di Stato e misure generali è fondamentale per massimizzare i benefici senza incorrere in rischi di esclusione o richieste di restituzione.

A cura di Silvestrini Barbara
Responsabile Area Bandi e Opportunità